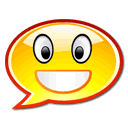
NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
14 dicembre 2011 - Parere Penale
1769 messaggi, letto 112478 volte Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
| Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ..., 54, 55, 56, 57, 58, 59 - Successiva >>
| Da: mike 2012 | 14/12/2011 12:40:50 |
| Dai cazzo mi serve il parere sull'abuso d'ufficio!!!! | |
| Da: johanna 82 | 14/12/2011 12:41:02 |
| ragazzi per cortesia dove si può trovare il contenuto della sentenza n. 989 codice penale traccia 2???? in internet non c'è nulla. Chi la trova la posta qui?? | |
| Da: Avvocato del demonio | 14/12/2011 12:41:04 |
- Messaggio eliminato - | |
| Da: Ester Esposito | 14/12/2011 12:42:06 |
- Messaggio eliminato - | |
| Da: mike 2012 | 14/12/2011 12:42:18 |
| Il parere di Anemone è giusto???? | |
| Da: yo | 14/12/2011 12:42:31 |
| X Riccardo Benzoni | |
 | E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
| Da: BRAVO | 14/12/2011 12:42:39 |
| lUXOR DOV'E? | |
| Da: ser | 14/12/2011 12:42:39 |
| mi serve risolvere la traccia 2 per favoreeeeeeeee | |
| Da: Silvia83 | 14/12/2011 12:42:45 |
| Servono soluzioni!!! Che ansia... | |
| Da: speranzosa | 14/12/2011 12:42:46 |
| traccia n 2 appropriazione indebita aggravata | |
| Da: Chiara23 | 14/12/2011 12:43:27 |
- Messaggio eliminato - | |
| Da: X NAPOLI | 14/12/2011 12:43:41 |
| STANNO CONTROLLANDO TANTISSIMO E DENTRO NON SANNO COSA FARE....POCHE IDEE E CONFUSE...VI PREGO AIUTO IO SONO CIVILISTA E NON CI CAPISCO UNA MAZZA | |
| Da: Ela | 14/12/2011 12:43:45 |
| CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA': Querela per il reato di appropriazione indebita - decorrenza del dies a quo dal rifiuto ingiustificato della restituzione della cosa dopo la scadenza del termine che ne legittima il possesso - allegazione della prova della intempestività - incertezza della decorrenza del termine: improcedibilità per favor rei. Sentenza emessa l'11.04.03 dal Tribunale Penale di Nola Giudice Monocratico Dott.ssa Tamara De Amicis. ______________________________________________ MOTIVAZIONE Con decreto emesso in data 22.1.2002 il Pubblico ministero presso questo Tribunale ha disposto la citazione a giudizio di F.A. e R.S per rispondere del reato di appropriazione indebita di gioielli del valore di oltre 5.000 Euro commesso in danno di C.L., aggravato dalla circostanza di aver cagionato alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, come analiticamente indicato in epigrafe. All'odierna udienza la parte offesa ha ritualmente presentato atto di costituzione di parte civile nei confronti di entrambi gli imputati. La costituzione della parte civile è stata ammessa soltanto nei confronti dell'imputato R.S.; viceversa, è stata rigettata nei confronti dell'imputata F.A. atteso che la stessa, dichiarata fallita con sentenza dell'11.11.1998, risulta priva della capacità processuale rispetto all'azione civile, nel caso di specie esercitata nel processo penale. Quindi, preliminarmente, la difesa degli imputati ha chiesto pronunciarsi sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p., eccependo l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela tempestivamente presentata ai sensi dell'art. 124 c.p. Ha rilevato la difesa che i rapporti tra gli odierni imputati e la persona offesa si inquadrano, sotto il profilo civilistico, nella figura del contratto di somministrazione: gli imputati avevano ricevuto in conto deposito alcuni gioielli (di cui alle bolle di accompagnamento allegate alla querela), rispettivamente nelle date del 16.9.1996, del 2.10.1996 e del 17.10.1996, concordando con l'imputato la corresponsione del prezzo, ovvero la restituzione della merce rimasta invenduta, entro i sessanta giorni successivi dall'ultima consegna. In mancanza della restituzione della merce ovvero del pagamento del prezzo convenuto, l'appropriazione indebita si sarebbe perfezionata il 17.12.1996, cioè alla scadenza del termine come sopra calcolato. Il difensore ha aggiunto che la decorrenza del termine di novanta giorni per la presentazione della querela va determinata non già sulla base della valutazione soggettiva dell'antigiuridicità penale del fatto operata dalla persona offesa, ma in relazione al momento in cui tutti gli elementi della fattispecie sono oggettivamente noti alla stessa. Pertanto, nel caso di specie, avendo la parte offesa contezza della circostanza essenziale costituita dalla scadenza del termine per la restituzione della merce (in ipotesi, ovviamente, che fosse rimasta invenduta), già dal giorno successivo alla detta scadenza ben avrebbe potuto proporre querela per il reato in contestazione, perfezionatosi in tutti i suoi elementi oggettivamente noti all'interessato. La circostanza che il querelante abbia dichiarato di essere venuto a conoscenza soltanto nei mesi successivi della volontà degli imputati di non restituire i beni non consente - sempre ad avviso del difensore - di spostare in avanti il dies a quo per la proposizione della querela; diversamente si finirebbe per dare rilievo giuridico, sia pur soltanto agli effetti della proponibilità della querela, ad una particolare figura di ignoranza sul fatto che costituisce il reato. La difesa di parte civile ha manifestato la propria opposizione alla richiesta dell'imputato evidenziando l'esistenza di un rapporto fiduciario tra le parti che avrebbe spostato in avanti nel tempo la consapevolezza della parte offesa in ordine alla volontà degli imputati di appropriarsi indebitamente della merce loro consegnata. Il pubblico ministero si è rimesso alle determinazioni del Tribunale. Ritiene il giudicante che emerga, dal contenuto stesso della querela, la tardività della proposizione di essa ai sensi dell'art. 124 c.p. Richiamato quanto precisato dalla difesa in ordine al nomen iuris del contratto concluso dalle parti, ed ai termini dell'accordo concernente la restituzione del bene, occorre formulare alcune ulteriori considerazioni sul momento in cui la fattispecie di reato può ritenersi perfezionata. Secondo costante e condivisibile giurisprudenza, il reato di cui all'art. 646 c.p. si consuma nel momento dell'interversione del titolo del possesso, momento che non coincide necessariamente con quello della scadenza del termine stabilito per la restituzione (in quanto la mancata restituzione colposa non integra gli estremi del reato) né con quello dell'alienazione della cosa da parte del possessore che può essere preceduta dall'interversione. Il rifiuto ingiustificato della restituzione della cosa dopo la scadenza del termine che ne legittima il possesso (salvo che sia ascrivibile a colpa) rende manifesta l'esistenza sia dell'elemento oggettivo, per il venir meno della legittimità del possesso, sia di quello soggettivo evidenziando la volontà del possessore di invertire il titolo del possesso per trarre dalla cosa stessa un ingiusto profitto. In tale momento il reato deve ritenersi integrato in tutti i suoi elementi (cfr., ex plurimis, Cass. pen. II, 30.10.1986, n. 12096). Per la consumazione del reato occorrono dunque due elementi: da un lato, il rifiuto ingiustificato della restituzione, dall'altro l'elemento soggettivo del dolo specifico, caratterizzato dalla coscienza e volontà di conseguire la disponibilità esclusiva e definitiva del bene altrui allo scopo di trarne un profitto. Nella presente decisione non è necessario discutere dell'elemento soggettivo, atteso che l'eccezione sollevata dalla difesa verte su una problematica che impedisce di valutare il merito della condotta ascritta agli imputati, ovvero - sostanzialmente - le ragioni che hanno determinato (se l'ipotesi accusatoria fosse fondata almeno nelle sue connotazioni oggettive) la mancata restituzione della merce. Occorre, viceversa, formulare alcune considerazioni in merito all'atteggiarsi del rifiuto ingiustificato di restituire il bene. Da una parte, può senza dubbio affermarsi che la mancata restituzione del bene alla scadenza convenzionalmente stabilita integra un inadempimento di natura civilistica, di per sé non idoneo a far ritenere consumato il reato. Dall'altra, occorre chiedersi se sia necessario o soltanto possibile che la parte offesa formalizzi un atto contenente una richiesta di restituzione in un termine perentorio, idoneo a rendere esplicita - eventualmente anche a mezzo di una mancata ottemperanza alla richiesta, e perciò con un comportamento concludente - la volontà di modificare il titolo del possesso da parte dell'imputato. La formale richiesta fatta dalla parte offesa in un tempo successivo alla scadenza del termine convenzionalmente pattuito per la restituzione rende certa - sotto il profilo probatorio - la volontà di invertire il titolo del possesso; tuttavia, sembrerebbe - almeno prima facie - esporre l'imputato alla discrezionalità della parte offesa nella individuazione del dies a quo per la presentazione della querela, eventualmente spostandolo in avanti pur in casi in cui la parte fosse già precedentemente a conoscenza della volontà dell'imputato di commettere il reato; con conseguenze all'evidenza importanti, soprattutto nei casi in cui tali date siano piuttosto lontane tra loro, in ordine alla procedibilità dell'azione penale. Allo scopo di contemperare le indicate esigenze, di certezza e di favor rei, deve ritenersi innanzitutto che la parte offesa non abbia alcun obbligo di esplicitare formali richieste di restituzione, ma soltanto - eventualmente - un "onere" che renderà più agevole, sotto il profilo probatorio, evidenziare l'elemento soggettivo dell'imputato. In ogni caso, la facoltà di avanzare una formale richiesta di restituzione deve essere contemperata con il principio per cui il termine per proporre querela comincia a decorrere dal momento in cui il titolare del relativo diritto si sia reso conto di tutte le connotazioni oggettive e soggettive necessarie per l'integrazione del reato. Ne consegue che la formale richiesta di restituzione non potrà valere comunque a spostare in avanti, a discrezione della parte, il termine di cui all'art. 124 c.p. Spetta quindi, comunque, al giudice valutare se e quanto il titolare del diritto di querela abbia avuto conoscenza di tutti gli elementi necessari per proporre fondatamente istanza di punizione per un determinato delitto; con la conseguenza che non si potrà tenere conto di quanto apoditticamente affermato dal querelante in merito al tempo della conoscenza, da parte sua, di alcuni degli elementi costitutivi della fattispecie. Non ignora, questo giudicante, che parte della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "in ogni caso l'onere della prova dell'intempestività incombe su chi la allega e a tal fine non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova rigorosa" (Cass. pen. sez. V, 27.3.1992, n. 3671). Ritiene tuttavia che tale prova sia, in casi come quello di specie, impossibile; nel senso che, in mancanza di una formale richiesta di restituzione, all'imputato non è data altra possibilità che quella di affidarsi a presunzioni, purchè siano dal giudice valutate come dotate di preciso rigore logico. Per tornare ancora alla fattispecie concreta, si evidenzia che - in relazione all'eccezione sollevata - il solo elemento in possesso dell'imputato è costituito dall'atto di querela e dalle bolle di accompagnamento che attestano l'effettiva consegna della merce nelle date indicate. La parte offesa afferma che "da accordi verbali intercorsi tra le parti al momento delle consegne, la F.A. ed il R. S. si impegnarono, entro 60 gg., a pagare allo scrivente la merce venduta oppure a restituirgliela nel caso rimanesse invenduta". Il tenore dell'espressione connota il termine indicato in termini di perentorietà, e comunque evidenzia la possibilità che la parte offesa, decorsi i sessanta giorni, si attivasse in qualche modo per uscire da una eventuale situazione di incertezza in merito alla sorte dell'obbligazione. D'altra parte, anche successivamente la parte offesa evidenzia la propria consapevolezza che dal momento fissato per la restituzione al momento della proposizione della querela erano trascorsi circa nove mesi, ovvero un termine di gran lunga maggiore rispetto a quello indicato dall'art. 124 c.p. ("Sono passati circa 9 mesi dal giorno dell'ultima consegna, ed all'istante non è stato pagato o restituito alcunché!"). Le successive affermazioni, di aver sollecitato più volte gli imputati a saldare il debito e di aver avuto soltanto "ultimamente" la consapevolezza della volontà di costoro di invertire il titolo del possesso, sono, a parere del giudicante, dati del tutto sforniti di prova, come tali non idonei a spostare in avanti - in danno dell'imputato - il dies a quo per la proposizione della querela, soprattutto ove si consideri il notevole lasso di tempo (nove mesi) intercorso tra la scadenza del termine per la restituzione e l'istanza di punizione. Peraltro, tra gli atti allegati alla querela manca proprio quella diffida formale, finalizzata alla restituzione, che la parte asserisce di aver rivolto agli imputati nel momento in cui si rese conto della loro volontà di non restituire i gioielli consegnati (" â�� il predetto, ultimamente, vistosi in forte difficoltà, ed avuta la consapevolezza della mancanza di volontà da parte dei nominati F.A. e R.S. di pagare o riconsegnare i preziosi indicati, è stato costretto a diffidarli formalmente al pagamento della merce o del loro corrispettivo in denaro"). Pertanto, se è vero che la decorrenza del termine di cui all'art. 124 c.p. non può essere calcolata - come prospettato dalla difesa - dal 17.12.1996, è pur vero che la connotazione dell'accordo intercorso tra le parti era tale da consentire di acquisire la conoscenza della volontà di non restituzione già dai giorni immediatamente successivi alla data di scadenza del termine. Non vi è dubbio che, in casi come quello indicato, il dies a quo per la formalizzazione dell'istanza punitiva presenta qualche incertezza, elemento che non può tuttavia risolversi in danno dell'imputato, dilatando irragionevolmente la possibilità di essere sottoposto a procedimento penale. Soccorre, in tali situazioni, il dovere del giudicante di valutare prudentemente la prospettazione delle parti in ordine all'eccezione di tardività, evidenziando gli elementi che consentano - in modo quanto più possibile aderente alla realtà - di collocare precisamente nel tempo la data di consumazione del reato. Nel caso di specie, tenuto conto di quanto in precedenza esposto, appare evidente che la parte offesa abbia avuto piena cognizione degli elementi costitutivi del reato fin dai giorni immediatamente successivi al 17.12.1996; né, per sostenere il contrario, può attribuirsi rilievo a mere dichiarazioni della stessa parte del tutto sfornite di prova. La querela presentata in data 11.7.1997 risulta perciò sicuramente tardiva. P.Q.M. Visto l'art. 129 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di F. A. e R. S. in ordine al reato loro ascritto in rubrica per difetto di tempestiva querela. Nola, 11/4/2003 Il Giudice Dott.ssa Tamara De Amicis | |
| Da: ... | 14/12/2011 12:43:48 |
| Sapete come sta andando a MESSINA? | |
| Da: ale | 14/12/2011 12:43:50 |
| Appropriazione indebita. Cass., Sez. II Pen., 13 settembre 2011, n. 33839 ott 11, 2011da Redazione Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 13 settembre 2011, n. 33839 - Pres. Fiandanese, est. D'Arrigo La massima In tema di appropriazione indebita, il bene oggetto del reato deve essere costituito dal denaro o da altro bene mobile comunque suscettibile di fisica apprensione. Pertanto, difettando il carattere della materialità, non sono suscettibili di appropriazione indebita i crediti di cui taluno abbia la giuridica disponibilità per conto d'altri (come può avvenire nei casi di mandato, commissione, agenzia, mediazione, ecc), a meno che tali crediti non siano divenuti equiparabili alle cose mobili per effetto della "incorporazione" in un documento (ad esempio, un titolo di credito). La sentenza Fatto e diritto Con sentenza del 12 ottobre 2010 la Corte d'appello di Bari - riformando in toto la sentenza pronunciata in data 30 aprile 2008 dal Tribunale di Trani - assolveva S.P. dal reato di appropriazione indebita dell'importo di Euro 73.262,16 consistente in premi assicurativi riscossi dai propri subagenti e che, nella qualità di agente, avrebbe dovuto corrispondere alla compagna assicurativa Progress Assicurazioni s.p.a. La corte territoriale osservava, in particolare, che non vi era prova che il S. avesse mai incassato quei premi assicurativi - risultando, al contrario, che i subagenti erano stati inadempienti - e che quindi non sarebbe ravvisabile l'indebita appropriazione degli stessi. Avverso tale pronunzia ha proposto appello la parte civile Progress Assicurazioni s.p.a. (nel frattempo posta in l.c.a.), allegando due motivi. Col primo, la parte civile contesta il concetto restrittivo e strettamente materiale di 'possesso' fatto proprio dalla Corte dТappello, osservando che il S., pur non detenendole materialmente, aveva comunque la giuridica disponibilità di quelle somme, in quanto vantava corrispondenti crediti nei confronti dei subagenti obbligati nei suoi confronti. Col secondo motivo il provvedimento impugnato è censurato sub specie di vizio di motivazione, per il fatto di aver prestato maggior credito alla versione dei fatti fornita dall'imputato - secondo cui i subagenti erano a loro volta tutti inadempimenti -piuttosto che a quanto dichiarato in proposito da alcuni dei testimoni escussi (in particolare, i testi R.L. e C.N.). Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. I due motivi devono essere esaminati in ordine invertito, in quanto non vi sarebbe ragione di discutere dell'ampiezza del concetto di 'possesso' penalmente rilevante se si ritenesse comprovato che il S. ricevette materialmente il denaro da parte dei suoi subagenti. La questione assumerebbe rilievo solamente se si prestasse fede alla versione opposta, fatta propria dai giudici di appello, secondo cui l'imputato non incassò mai dai subagenti le somme che avrebbe dovuto riversare alla compagnia assicurativa. Ciò posto, il denunciato vizio di motivazione non sussiste. La deposizione dei testi R. e C., di cui la Corte d'appello non avrebbe tenuto debito conto, non avalla in modo univoco la tesi sostenuta dalla parte civile. In particolare, il teste R., ispettore amministrativo della Progress Assicurazioni s.p.a., ha dichiarato di aver accertato che l'agenzia di S. presentava un saldo di cassa per rimesse di polizze pagate dai clienti non versate alla compagnia di circa Euro 73.263,00. La deposizione nulla dice circa i rapporti fra il S. ed i subagenti ed il teste non precisa se gli importi riscontrati contabilmente erano nella materiale disponibilità dell'imputato. L'uso dell'espressione "saldo di cassa" non è, da solo, indicativo della disponibilità di denaro contante, non essendo certo che l'espressione sia stata usata in senso tecnico ed anzi trasparendo dal tenore complessivo della deposizione che quell'importo costituiva solo una risultanza contabile. La teste C., direttore commerciale della Progress Assicurazioni s.p.a., ha invece espressamente dichiarato di aver avuto notizie di problemi intercorsi fra il S. ed almeno uno dei suoi subagenti, ma ha liquidato la questione osservando "comunque questi sono fatti che alla Compagnia non riguardano perchè il rapporto ш diretto con l'agente e l'agente risponde dei suoi rapporti con il subagente". La tesi è stata poi avallata dal giudice di primo grado, che ha ritenuto l'irrilevanza dei rapporti interni fra l'agente ed i subagenti sulla base della clausola contenuta nell'art. 6 del contratto di agenzia. Ma, all'evidenza, la clausola che pone la responsabilità per i fatti dei subagenti in capo allТagente opera sul piano dellТinadempimento civilistico e non interferisce con la ricostruzione in punto di fatto ritenuta dalla Corte d'appello. Nella sentenza di appello - che ha riformato quella di primo grado - non vi è quindi alcun travisamento dei fatti, dal momento che le risultanze processuali indicate in ricorso non depongono in modo univoco nel senso sostenuto dalla parte civile. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione ш fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456). Queste conclusioni restano ferme pur dopo la legge n. 46 del 2000 che, innovando sul punto l'art. 606 lett. e) c.p.c., consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad 'altri atti del processo': alla Corte di cassazione resta comunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitр esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (ex plurimis: Cass. 1 ottobre 2008 n. 38803). Quindi, pur dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546; Cass. 10 luglio 2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380). Alla luce di tali principi e considerato l'effettivo contenuto degli elementi di prova indicati in ricorso, deve escludersi che la sentenza di appello contenga vizi di motivazione. La tesi della parte civile ricorrente costituisce solamente una prospettazione alternativa di merito, non rilevante in sede di legittimità. Il secondo motivo di ricorso deve essere quindi rigettato. Tali conclusioni impongono l'esame del primo motivo di ricorso che - come si è detto in precedenza - è in realtà logicamente subordinato al rigetto della censura relativa al vizio di motivazione. Nella sentenza di primo grado - poi riformata in appello - l'inadempimento civilistico è stato ritenuto perfettamente sovrapponibile alla fattispecie penale di appropriazione indebita. La parte civile sostiene che bene avrebbe deciso il giudice di primo grado ed invece sarebbe erronea la sentenza di appello, in quanto fondata su un'interpretazione del concetto di possesso estremamente restrittiva e dunque erronea. In particolare, afferma che l'imputato, pur senza aver riscosso le somme dovutegli dai subagenti, ne avesse comunque la disponibilità giuridica "atteso che le somme di denaro dovute alla compagnia assicurativa offerivano all'insieme dei beni nella disponibilità di quest'ultimo, disponibilità caratterizzata dalla titolarità del diritto di credito vantata nei confronti dei subagenti". Si afferma, in altri termini, che la conclusione del contratto assicurativo, comprensivo del premio intascato dal subagente, "determina la signoria piena dell'agente sul credito riscosso e dunque sull'esistenza -nel senso giuridico - della somma indicata, indipendentemente dalla materiale apprensione in capo". La questione ruota, in apparenza, intorno al concetto giuridico di 'possesso' rilevante nella fattispecie di cui all'art. 646 c.p.. Ma, a ben vedere, l'argomento sviluppato dalla parte civile conduce alla domanda conclusiva se ci si possa indebitamente appropriare anche dei crediti altrui nell'ambito di rapporti quali mandato, agenzia ed affini. O, più esattamente, se il potere dell'agente di riscuotere (art. 1744 c.c.) i crediti pecuniari per conto del preponente implichi in capo al primo la giuridica disponibilità della somma, tanto da potersene indebitamente appropriare prima ancora - o comunque a prescindere dal fatto - di aver materialmente riscosso la prestazione. Al quesito deve essere data risposta negativa. L'art. 646 c.p. indica, quali possibili oggetti dell'appropriazione indebita, il denaro o le cose mobili. Come recentemente osservato da questa Corte, "per cosa mobile deve intendersi qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione e che sia in grado di spostarsi autonomamente ovvero di essere trasportata da un luogo ad un altro, compresa quella che, pur non mobile originariamente, sia resa tale mediante l'avulsione o l'enucleazione dal complesso immobiliare di cui faceva parte" (Cass. 11 maggio 2010, n. 20647). La nozione penalistica di cosa mobile non coincide quindi con quella civilistica, rivelandosi per certi aspetti più ridotta, in particolare laddove non considera cose mobili le entità immateriali - come le opere dell'ingegno ed i diritti soggettivi - che, invece, l'art. 813 c.c., assimila ai beni mobili. Tale nozione non è dunque comprensiva dei diritti soggettivi in genere e dei crediti in particolare che, in quanto beni immateriali, non sono suscettibili di fisica appropriazione. L'espressa menzione del denaro potrebbe, a rigor di termini, apparire pleonastica, essendo anch'esso una cosa mobile. Ed invece, questa specificazione serve a chiarire che anche il danaro può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, nonostante la sua ontologica fungibilità che, sotto il profilo degli effetti civili, comporta l'immediato trasferimento della proprietà unitamente al possesso, con l'obbligo eventualmente previsto dal titolo di restituire il tantundem. Dal punto di vista penalistico, invece, proprio in virtù della precisazione contenuta nell'art. 646 c.p. al trasferimento del possesso non si accompagna necessariamente anche quello della proprietà, come accade nei casi di deposito, di custodia o di consegna del danaro con un preciso vincolo di scopo: in questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del titolare del denaro e ove ciò avvenga si commette il delitto di appropriazione indebita (Cass. 25 ottobre 1972, n. 4584). Anche il denaro, pertanto, deve essere inteso nella sua accezione materiale di bene mobile, e non come utilità 'mediata', ossia quale oggetto della prestazione di un debito pecuniario. La espressa dicitura contenuta nell'art. 646 c.p. trova la sua giustificazione nell'esigenza di superare il principio civilistico valevole per le cose fungibili, ma non sta affatto a significare che l'appropriazione indebita possa riguardare, oltre le cose mobili, anche i crediti pecuniari. Infatti, poichè la fattispecie di cui allТart. 646 c.p. presuppone - quale elemento minino essenziale della condotta incriminatrice - l'atto materiale dell'appropriazione, l'oggetto dell'azione delittuosa deve essere costituito necessariamente da un bene mobile suscettibile di essere fisicamente appreso. Tali non si rivelano i diritti di credito, a meno che non siano 'incorporati' in un documento (come nel caso dei titoli di credito). La questione illustrata nel ricorso non è quindi pertinente. La delimitazione della nozione penalistica di 'possesso' giova a circoscrivere l'area dei beni di cui l'agente si può indebitamente appropriare da quelli che altrimenti costituiscono oggetto di furto. Si tratta, quindi, di una qualificazione che traccia un sottoinsieme all'interno delle cose mobili o del denaro; un concetto che, per dirla in altri termini, deve essere applicato dopo quello di 'bene mobile'. Non tutti i beni giuridici di cui l'agente ha la disponibilità giuridica sono suscettibili di appropriazione indebita, ma solo i beni mobili ed il denaro. Il ragionamento esposto nel ricorso in esame non tiene, invece, conto di quest'ultimo passaggio ed indica la relazione di 'possesso' fra il soggetto attivo ed il bene come l'unico criterio selettivo delle cose suscettibili di appropriazione indebita; in tal modo si giunge quindi all'inappropriata conclusione che i crediti, di cui lТagente ha la giuridica disponibilitр, possono essere indebitamente appresi. Si trascura però di considerare il dato decisivo che il bene, ancor prima che posseduto dall'agente, deve essere astrattamente suscettibile di fisica apprensione e quindi deve essere un bene materiale. In conclusione, deve essere affermato il seguente principio di diritto. In tema di appropriazione indebita, il bene oggetto del reato deve essere costituito dal denaro o da altro bene mobile comunque suscettibile di fisica apprensione. Pertanto, difettando il carattere della materialità, non sono suscettibili di appropriazione indebita i crediti di cui taluno abbia la giuridica disponibilità per conto d'altri (come può avvenire nei casi di mandato, commissione, agenzia, mediazione, ecc), a meno che tali crediti non siano divenuti equiparabili alle cose mobili per effetto della 'incorporazione' in un documento (ad esempio, un titolo di credito). Piuttosto, commette il reato di cui all'art. 646 c.p. l'agente che, solo dopo aver effettivamente riscosso la prestazione, se ne appropri senza rivolgerla in favore all'avente diritto. Poichè la sentenza di appello si ш sostanzialmente conformata al principio testè esposto, il ricorso deve essere rigettato anche sotto questo profilo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la societр ricorrente al pagamento delle spese processuali. Articoli correlati chiudi Appropriazione indebita. Cass., Sez. II Pen., 24 giugno 2011, n. 25344 Indennità di espropriazione. Cass., Sez. I Civ., 29 settembre 2011, n. 19938 Pubblico impiego. Tar Lazio - ROMA, Sez. I ter, 21 settembre 2011, n. 7481 | |
| Da: ale | 14/12/2011 12:43:52 |
| Appropriazione indebita. Cass., Sez. II Pen., 13 settembre 2011, n. 33839 ott 11, 2011da Redazione Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 13 settembre 2011, n. 33839 - Pres. Fiandanese, est. D'Arrigo La massima In tema di appropriazione indebita, il bene oggetto del reato deve essere costituito dal denaro o da altro bene mobile comunque suscettibile di fisica apprensione. Pertanto, difettando il carattere della materialità, non sono suscettibili di appropriazione indebita i crediti di cui taluno abbia la giuridica disponibilità per conto d'altri (come può avvenire nei casi di mandato, commissione, agenzia, mediazione, ecc), a meno che tali crediti non siano divenuti equiparabili alle cose mobili per effetto della "incorporazione" in un documento (ad esempio, un titolo di credito). La sentenza Fatto e diritto Con sentenza del 12 ottobre 2010 la Corte d'appello di Bari - riformando in toto la sentenza pronunciata in data 30 aprile 2008 dal Tribunale di Trani - assolveva S.P. dal reato di appropriazione indebita dell'importo di Euro 73.262,16 consistente in premi assicurativi riscossi dai propri subagenti e che, nella qualità di agente, avrebbe dovuto corrispondere alla compagna assicurativa Progress Assicurazioni s.p.a. La corte territoriale osservava, in particolare, che non vi era prova che il S. avesse mai incassato quei premi assicurativi - risultando, al contrario, che i subagenti erano stati inadempienti - e che quindi non sarebbe ravvisabile l'indebita appropriazione degli stessi. Avverso tale pronunzia ha proposto appello la parte civile Progress Assicurazioni s.p.a. (nel frattempo posta in l.c.a.), allegando due motivi. Col primo, la parte civile contesta il concetto restrittivo e strettamente materiale di 'possesso' fatto proprio dalla Corte dТappello, osservando che il S., pur non detenendole materialmente, aveva comunque la giuridica disponibilità di quelle somme, in quanto vantava corrispondenti crediti nei confronti dei subagenti obbligati nei suoi confronti. Col secondo motivo il provvedimento impugnato è censurato sub specie di vizio di motivazione, per il fatto di aver prestato maggior credito alla versione dei fatti fornita dall'imputato - secondo cui i subagenti erano a loro volta tutti inadempimenti -piuttosto che a quanto dichiarato in proposito da alcuni dei testimoni escussi (in particolare, i testi R.L. e C.N.). Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. I due motivi devono essere esaminati in ordine invertito, in quanto non vi sarebbe ragione di discutere dell'ampiezza del concetto di 'possesso' penalmente rilevante se si ritenesse comprovato che il S. ricevette materialmente il denaro da parte dei suoi subagenti. La questione assumerebbe rilievo solamente se si prestasse fede alla versione opposta, fatta propria dai giudici di appello, secondo cui l'imputato non incassò mai dai subagenti le somme che avrebbe dovuto riversare alla compagnia assicurativa. Ciò posto, il denunciato vizio di motivazione non sussiste. La deposizione dei testi R. e C., di cui la Corte d'appello non avrebbe tenuto debito conto, non avalla in modo univoco la tesi sostenuta dalla parte civile. In particolare, il teste R., ispettore amministrativo della Progress Assicurazioni s.p.a., ha dichiarato di aver accertato che l'agenzia di S. presentava un saldo di cassa per rimesse di polizze pagate dai clienti non versate alla compagnia di circa Euro 73.263,00. La deposizione nulla dice circa i rapporti fra il S. ed i subagenti ed il teste non precisa se gli importi riscontrati contabilmente erano nella materiale disponibilità dell'imputato. L'uso dell'espressione "saldo di cassa" non è, da solo, indicativo della disponibilità di denaro contante, non essendo certo che l'espressione sia stata usata in senso tecnico ed anzi trasparendo dal tenore complessivo della deposizione che quell'importo costituiva solo una risultanza contabile. La teste C., direttore commerciale della Progress Assicurazioni s.p.a., ha invece espressamente dichiarato di aver avuto notizie di problemi intercorsi fra il S. ed almeno uno dei suoi subagenti, ma ha liquidato la questione osservando "comunque questi sono fatti che alla Compagnia non riguardano perchè il rapporto ш diretto con l'agente e l'agente risponde dei suoi rapporti con il subagente". La tesi è stata poi avallata dal giudice di primo grado, che ha ritenuto l'irrilevanza dei rapporti interni fra l'agente ed i subagenti sulla base della clausola contenuta nell'art. 6 del contratto di agenzia. Ma, all'evidenza, la clausola che pone la responsabilità per i fatti dei subagenti in capo allТagente opera sul piano dellТinadempimento civilistico e non interferisce con la ricostruzione in punto di fatto ritenuta dalla Corte d'appello. Nella sentenza di appello - che ha riformato quella di primo grado - non vi è quindi alcun travisamento dei fatti, dal momento che le risultanze processuali indicate in ricorso non depongono in modo univoco nel senso sostenuto dalla parte civile. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione ш fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456). Queste conclusioni restano ferme pur dopo la legge n. 46 del 2000 che, innovando sul punto l'art. 606 lett. e) c.p.c., consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad 'altri atti del processo': alla Corte di cassazione resta comunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitр esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (ex plurimis: Cass. 1 ottobre 2008 n. 38803). Quindi, pur dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546; Cass. 10 luglio 2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380). Alla luce di tali principi e considerato l'effettivo contenuto degli elementi di prova indicati in ricorso, deve escludersi che la sentenza di appello contenga vizi di motivazione. La tesi della parte civile ricorrente costituisce solamente una prospettazione alternativa di merito, non rilevante in sede di legittimità. Il secondo motivo di ricorso deve essere quindi rigettato. Tali conclusioni impongono l'esame del primo motivo di ricorso che - come si è detto in precedenza - è in realtà logicamente subordinato al rigetto della censura relativa al vizio di motivazione. Nella sentenza di primo grado - poi riformata in appello - l'inadempimento civilistico è stato ritenuto perfettamente sovrapponibile alla fattispecie penale di appropriazione indebita. La parte civile sostiene che bene avrebbe deciso il giudice di primo grado ed invece sarebbe erronea la sentenza di appello, in quanto fondata su un'interpretazione del concetto di possesso estremamente restrittiva e dunque erronea. In particolare, afferma che l'imputato, pur senza aver riscosso le somme dovutegli dai subagenti, ne avesse comunque la disponibilità giuridica "atteso che le somme di denaro dovute alla compagnia assicurativa offerivano all'insieme dei beni nella disponibilità di quest'ultimo, disponibilità caratterizzata dalla titolarità del diritto di credito vantata nei confronti dei subagenti". Si afferma, in altri termini, che la conclusione del contratto assicurativo, comprensivo del premio intascato dal subagente, "determina la signoria piena dell'agente sul credito riscosso e dunque sull'esistenza -nel senso giuridico - della somma indicata, indipendentemente dalla materiale apprensione in capo". La questione ruota, in apparenza, intorno al concetto giuridico di 'possesso' rilevante nella fattispecie di cui all'art. 646 c.p.. Ma, a ben vedere, l'argomento sviluppato dalla parte civile conduce alla domanda conclusiva se ci si possa indebitamente appropriare anche dei crediti altrui nell'ambito di rapporti quali mandato, agenzia ed affini. O, più esattamente, se il potere dell'agente di riscuotere (art. 1744 c.c.) i crediti pecuniari per conto del preponente implichi in capo al primo la giuridica disponibilità della somma, tanto da potersene indebitamente appropriare prima ancora - o comunque a prescindere dal fatto - di aver materialmente riscosso la prestazione. Al quesito deve essere data risposta negativa. L'art. 646 c.p. indica, quali possibili oggetti dell'appropriazione indebita, il denaro o le cose mobili. Come recentemente osservato da questa Corte, "per cosa mobile deve intendersi qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione e che sia in grado di spostarsi autonomamente ovvero di essere trasportata da un luogo ad un altro, compresa quella che, pur non mobile originariamente, sia resa tale mediante l'avulsione o l'enucleazione dal complesso immobiliare di cui faceva parte" (Cass. 11 maggio 2010, n. 20647). La nozione penalistica di cosa mobile non coincide quindi con quella civilistica, rivelandosi per certi aspetti più ridotta, in particolare laddove non considera cose mobili le entità immateriali - come le opere dell'ingegno ed i diritti soggettivi - che, invece, l'art. 813 c.c., assimila ai beni mobili. Tale nozione non è dunque comprensiva dei diritti soggettivi in genere e dei crediti in particolare che, in quanto beni immateriali, non sono suscettibili di fisica appropriazione. L'espressa menzione del denaro potrebbe, a rigor di termini, apparire pleonastica, essendo anch'esso una cosa mobile. Ed invece, questa specificazione serve a chiarire che anche il danaro può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, nonostante la sua ontologica fungibilità che, sotto il profilo degli effetti civili, comporta l'immediato trasferimento della proprietà unitamente al possesso, con l'obbligo eventualmente previsto dal titolo di restituire il tantundem. Dal punto di vista penalistico, invece, proprio in virtù della precisazione contenuta nell'art. 646 c.p. al trasferimento del possesso non si accompagna necessariamente anche quello della proprietà, come accade nei casi di deposito, di custodia o di consegna del danaro con un preciso vincolo di scopo: in questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del titolare del denaro e ove ciò avvenga si commette il delitto di appropriazione indebita (Cass. 25 ottobre 1972, n. 4584). Anche il denaro, pertanto, deve essere inteso nella sua accezione materiale di bene mobile, e non come utilità 'mediata', ossia quale oggetto della prestazione di un debito pecuniario. La espressa dicitura contenuta nell'art. 646 c.p. trova la sua giustificazione nell'esigenza di superare il principio civilistico valevole per le cose fungibili, ma non sta affatto a significare che l'appropriazione indebita possa riguardare, oltre le cose mobili, anche i crediti pecuniari. Infatti, poichè la fattispecie di cui allТart. 646 c.p. presuppone - quale elemento minino essenziale della condotta incriminatrice - l'atto materiale dell'appropriazione, l'oggetto dell'azione delittuosa deve essere costituito necessariamente da un bene mobile suscettibile di essere fisicamente appreso. Tali non si rivelano i diritti di credito, a meno che non siano 'incorporati' in un documento (come nel caso dei titoli di credito). La questione illustrata nel ricorso non è quindi pertinente. La delimitazione della nozione penalistica di 'possesso' giova a circoscrivere l'area dei beni di cui l'agente si può indebitamente appropriare da quelli che altrimenti costituiscono oggetto di furto. Si tratta, quindi, di una qualificazione che traccia un sottoinsieme all'interno delle cose mobili o del denaro; un concetto che, per dirla in altri termini, deve essere applicato dopo quello di 'bene mobile'. Non tutti i beni giuridici di cui l'agente ha la disponibilità giuridica sono suscettibili di appropriazione indebita, ma solo i beni mobili ed il denaro. Il ragionamento esposto nel ricorso in esame non tiene, invece, conto di quest'ultimo passaggio ed indica la relazione di 'possesso' fra il soggetto attivo ed il bene come l'unico criterio selettivo delle cose suscettibili di appropriazione indebita; in tal modo si giunge quindi all'inappropriata conclusione che i crediti, di cui lТagente ha la giuridica disponibilitр, possono essere indebitamente appresi. Si trascura però di considerare il dato decisivo che il bene, ancor prima che posseduto dall'agente, deve essere astrattamente suscettibile di fisica apprensione e quindi deve essere un bene materiale. In conclusione, deve essere affermato il seguente principio di diritto. In tema di appropriazione indebita, il bene oggetto del reato deve essere costituito dal denaro o da altro bene mobile comunque suscettibile di fisica apprensione. Pertanto, difettando il carattere della materialità, non sono suscettibili di appropriazione indebita i crediti di cui taluno abbia la giuridica disponibilità per conto d'altri (come può avvenire nei casi di mandato, commissione, agenzia, mediazione, ecc), a meno che tali crediti non siano divenuti equiparabili alle cose mobili per effetto della 'incorporazione' in un documento (ad esempio, un titolo di credito). Piuttosto, commette il reato di cui all'art. 646 c.p. l'agente che, solo dopo aver effettivamente riscosso la prestazione, se ne appropri senza rivolgerla in favore all'avente diritto. Poichè la sentenza di appello si ш sostanzialmente conformata al principio testè esposto, il ricorso deve essere rigettato anche sotto questo profilo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la societр ricorrente al pagamento delle spese processuali. Articoli correlati chiudi Appropriazione indebita. Cass., Sez. II Pen., 24 giugno 2011, n. 25344 Indennità di espropriazione. Cass., Sez. I Civ., 29 settembre 2011, n. 19938 Pubblico impiego. Tar Lazio - ROMA, Sez. I ter, 21 settembre 2011, n. 7481 | |
| Da: yo | 14/12/2011 12:43:55 |
| X Riccardo Benzoni Anch'io la sto impostando così! Ottimo! | |
| Da: alvi | 14/12/2011 12:44:42 |
| ma di quale anno la sentenza 989 | |
| Da: sos penale | 14/12/2011 12:44:57 |
| traccia due: appropriazione indebita. Propendere per la procedibilità d'ufficio, data la decorrenza dei termini per proporre querela, dopo aver ravvisato l'aggravante di cui al medesimo art. 646 o ex art 61 n.11 | |
| Da: x salerno | 14/12/2011 12:45:19 |
| come va a salerno?? | |
| Da: X MESSINA | 14/12/2011 12:46:26 |
| Come siete messi? | |
| Da: pippo80 | 14/12/2011 12:46:32 |
| PERSEGUIBILE D'UFFICIO L'APPROPRIAZIONE INDEBITA AGGRAVATA Cassazione, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 989 Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., l'espressione "abuso di relazioni di prestazione d'opera" abbraccia, nel suo significato, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che instaurino, comunque, tra le partì un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto. Cassazione, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 989 Motivi della decisione Con sentenza del 17.12.2009 il Tribunale di Ancona in composizione monocratica dichiarava non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di S.J. imputato di appropriazione indebita di oggetti consegnatigli in conto vendita. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona, contestando che l'impugnata sentenza è incorsa in violazione di legge per aver dichiarato estinto per intervenuta rimessione di querela un reato perseguibile di ufficio. Sostiene il ricorrente che in fatto era contestata l'aggravante 61 n. 11 c.p. (abuso di prestazioni d'opera) che, ai sensi del secondo comma dell'art. 646 c.p.p., determina la perseguibilità d'ufficio del reato. Il ricorso è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., l'espressione "abuso di relazioni di prestazione d'opera" abbraccia, nel suo significato, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che instaurino, comunque, tra le partì un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto. È evidente come nei caso in esame sia contestato in fatto l'aggravante in argomento, considerato che i beni indicati nel capo di imputazione erano stati dati all'imputato in conto vendita. Il reato era pertanto perseguibile d'ufficio. Sussiste la violazione di legge denunciata. Deve pertanto essere annullata la sentenza impugnata con rinvio avanti la Corte d'Appello di Ancona per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio avanti la Corte d'Appello di Ancona per il giudizio. | |
| Da: Ro Le | 14/12/2011 12:46:34 |
| X Ale.. secondo me non c'entra nulla la sentenza che hai postato... | |
| Da: ... | 14/12/2011 12:46:49 |
| com a st cazz.'.... | |
| Da: ZIA COSIMA | 14/12/2011 12:46:55 |
- Messaggio eliminato - | |
| Da: hevilina | 14/12/2011 12:46:59 |
| ragazzi ma dov'è il parere di anemone? | |
| Da: pol | 14/12/2011 12:47:23 |
| Abuso del titolo di legittimazione all'accesso ad un sistema informatico: alle SS.UU. la questione della configurabilità del delitto di cui all'art. 615 ter c.p. A proposito di Cass. pen., sez. V, ord. 11.2.2011 (dep. 23.3.2011), n. 11714, Pres. Calabrese, Est. Scalera, ric. Casani [Alberto Scirè] Si è già avuto occasione di dare notizia, in questa Rivista, della rimessione alle Sezioni Unite, da parte della quinta Sezione della Cassazione, della questione relativa all'integrazione del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) nel caso in cui l'agente sfrutti le proprie credenziali per scopi e finalità diverse da quelle in ragione delle quali le ha ricevute. Dal pronunciamento delle Sezioni Unite - atteso a breve - dipendono, in specie, le sorti di un maresciallo dei Carabinieri, il quale aveva fornito ad un conoscente dati riguardanti una terza persona tramite l'accesso al sistema informatico dell'Arma (denominato S.I.D., Sistema di Indagine), allo scopo di favorire un'operazione di dossieraggio. Ciò premesso, pare interessante svolgere qualche breve considerazione, quanto alle prospettive che aprirebbe un'interpretazione più o meno ampia, da parte delle Sezioni Unite, dei concetti di "abusività dell'accesso" e di "mantenimento" di un soggetto entro un determinato sistema informatico. 1. L'ordinanza della Quinta Sezione La Corte individua il perno delle motivazioni di ricorso presentate dai legali del Carabiniere (e riportate nell'ordinanza di rimessione, a pagina 2) nel carattere "abusivo" (o meno) della condotta posta in essere dall'agente, nel momento in cui egli, utilizzando le credenziali di accesso di cui era detentore autorizzato, trae dal sistema elementi non attinenti alle ragioni per cui esse gli sono state consegnate. La questione verte infatti sul dubbio se il legislatore, individuando un elemento del fatto tipico con l'espressione "accesso abusivo": - intendesse fare uso dello strumento penale al fine di proteggere informazioni riservate verso l'accesso da parte di chi non sia stato in precedenza identificato e abilitato, ovvero, in modo più ampio, - volesse individuare quale illecito (anche) ogni utilizzo delle credenziali non conforme alle prescrizioni previste dall'ente emittente. Da tale alternativa discendono alcune conseguenze di non scarsa rilevanza. La prima, e più evidente, è la possibilità (o meno) di configurare il reato di cui all'art. 615 ter a carico di soggetti legittimamente in possesso di password d'accesso, le quali siano loro fornite solo con un preciso scopo, allorché essi le utilizzino (come nel caso di specie) con modalità o per finalità diverse e ulteriori rispetto alla volontà del gestore dei dati. Ulteriore e più importante conseguenza della decisione demandata alle SS.UU. in tema di abusività dell'accesso è, però, la reale protezione che l'ordinamento intende riservare ai sistemi informatici, fortemente esposti ad accessi incontrollati, poiché per loro natura "immateriali" e facilmente consultabili da un ampio numero di soggetti. Si tratta insomma di decidere se un accesso sia intrinsecamente abusivo, e quindi rilevante ai sensi dell'art. 615 ter, ogniqualvolta l'attività dell'agente sia diretta ad una finalità diversa da quella prevista dall'ente emittente, ovvero se tale condotta integri, se del caso, un diverso profilo d'illiceità, non appartenente al gruppo dei "reati informatici". Su tale questione sono intervenute alcune importanti sentenze della stessa Corte di Cassazione (richiamate dall'ordinanza annotata), che prendono posizione a favore di una lettura "ampia" della norma, tale per cui si considera abusivo ogni accesso eccedente le finalità per cui le credenziali di autorizzazione sono fornite. Tale lettura individua, pertanto, il bene giuridico tutelato dalla norma in parola nella riservatezza dei dati contenuti nei sistemi informatici, e non nel mero "domicilio informatico" (così, ad esempio, si veda infra Cass. pen., n. 1727/2008, Romano). 2. La giurisprudenza di legittimità sull'art. 615 ter L'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite offre numerosi spunti di riflessione che traggono linfa dall'ampia casistica giurisprudenziale riportata: sono infatti menzionate sia sentenze che, in adesione all'orientamento estensivo, riconoscono la sussistenza del reato anche se il possesso delle password era di per sé legittimo (punto 3), sia sentenze in cui la Suprema Corte ha, invece, aderito all'interpretazione restrittiva della norma (punto 3a). La Quinta Sezione, dal canto suo, sembra riservare un maggior favore all'orientamento estensivo, il quale consentirebbe di qualificare senz'altro come "abusiva" la condotta dell'agente dell'Arma dei Carabinieri, che ha sfruttato il sistema informativo interno per scopi assolutamente estranei ai suoi doveri d'ufficio. I dubbi interpretativi qui discussi originano da una formulazione letterale poco precisa dell'art. 615 ter, laddove si parla di "chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo". La scelta di impiegare l'avverbio "abusivamente", anziché altre formule meno ambigue (come, ad esempio, "accesso non autorizzato") risulta, peraltro, in contrasto con la "Raccomandazione sulla criminalità informatica", adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 13 settembre 1989, la quale ha dato impulso all'emanazione, da parte del nostro legislatore, della legge n. 547 del 23 dicembre 1993, introduttiva di alcuni reati c.d. informatici (tra cui quello previsto all'art. 615 bis)[1]. Tale raccomandazione, citata spesso nelle sentenze che prediligono una lettura restrittiva dell'art. 615 ter c.p.[2], invita infatti gli Stati contraenti a punire il solo "accesso non autorizzato a sistemi informatici", vale a dire l'accesso illegittimo, avvenuto in mancanza di credenziali autentiche. Questa formula parrebbe invitare i singoli Stati a punire tutti (e solo) quei comportamenti che consistono nell'accedere ad un sistema senza esserne validamente autorizzati da chi detiene il c.d. "ius excludendi": in altre parole, se non ho ricevuto la password e me la procuro in modo illecito, non posso (e non devo) entrare nel sistema, pena la sanzione; se, invece, l'ho ricevuta, posso utilizzare il sistema liberamente. Questa seconda ipotesi (accesso autorizzato avvenuto, tuttavia, per finalitá diverse rispetto a quelle per cui l'autorizzazione era stata concessa), pur non integrando un "accesso abusivo", potrebbero, tuttavia, essere punita in forza di altre norme incriminatrici (a seconda delle circostanze di specie, frode informatica, illecita diffusione di dati personali, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, ecc.). Questi argomenti usati dai sostenitori della interpretazione restrittiva dell'art. 615 ter non tengono, tuttavia, conto - come rilevato da altra e contrastante giurisprudenza di legittimità[3] -, delle concrete modalità e motivazioni in base alle quali determinate credenziali d'accesso sono fornite ai più diversi soggetti, sia nel settore privato che in quello delle Amministrazioni pubbliche, e in particolare delle Forze Armate. La sentenza Zara del 2000, che aderisce all'orientamento estensivo, afferma che l'analogia con la violazione di domicilio "deve indurre a concludere che integri la fattispecie criminosa (prevista dall'art. 615 ter c.p.) anche chi, autorizzato all'accesso per una determinata finalità, utilizzi il titolo di legittimazione per una finalità diversa e, quindi, non rispetti le condizioni alle quali era subordinato l'accesso. Infatti, se l'accesso richiede un'autorizzazione e questa è destinata a un determinato scopo, l'utilizzazione dell'autorizzazione per uno scopo diverso non può non considerarsi abusiva.". La sentenza Romano del 2008, invero, va oltre: nel decidere in merito ad un'ordinanza cautelare relativa a numerosi reati, commessi da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, la Corte pare estendere alla formulazione per così dire "generica" del primo comma dell'art. 615 ter alcune considerazioni riferibili invece al secondo comma, ove si sanziona più gravemente la condotta del pubblico ufficiale che abbia commesso l'accesso al sistema informatico "con abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio". Questa sentenza critica la precedente sentenza Scimia per non aver considerato la norma nel suo complesso, trascurando quindi di comprendere a fondo quali siano tutte le diverse previsioni in merito al fatto tipico alla base dell'irrogazione della sanzione. 3. Le possibili "vie d'uscita" dal contrasto interpretativo Dalla lettura delle numerose pronunce in tema, un dato pare comunque emergere con forza: lo strumento informatico, sempre più diffuso non solo nella vita dei privati cittadini ma anche delle amministrazioni pubbliche, non può essere lasciato sprovvisto di tutela penale da parte dell'ordinamento, soprattutto per quanto concerne la gestione e la circolazione dei dati riconducibili a ciascuno di noi. Sono numerose, invero, le norme che puntano alla tutela delle informazioni, telematiche e non, nonché alla protezione dei sistemi da abusi e violazioni: esempi possono esserne l'art. 167 del c.d. Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003) il quale punisce la diffusione senza titolo di dati personali, con pene di una certa gravità, così come l'art. 640 ter c.p. in tema di frodi informatiche (spesso richiamato quale norma a portata più ampia di quella in discorso, che anzi sarebbe ivi ricompresa). Ma le concrete modalità con le quali le norme di diritto penale devono intervenire, nella loro attuale formulazione, sui c.d. "crimini informatici", sono fortemente dibattute. La norma (anche solo considerata nella sua formulazione letterale) pare infatti voler punire sia chi si introduca in un sistema senza averne la "chiave", sia chi - una volta entrato - si trattenga al suo interno per ragioni diverse che, se portate a conoscenza del soggetto che ha il diritto di escluderlo, ne provocherebbero, appunto, l'esclusione. Se l'espressione "abusivamente si introduce" non può che significare l'acquisizione senza autorizzazione di credenziali d'accesso, con modalità di più o meno sofisticato hackeraggio dei sistemi informatici, la successiva "vi si mantiene (nei sistemi) contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo" parrebbe invece voler individuare come fatto tipico rilevante ogni utilizzo contrario alla volontà del fornitore di password. Nel caso di specie, relativo all'Arma dei Carabinieri si potrebbe quindi provare ad ipotizzare che (a) il giuramento militare, (b) i doveri d'ufficio, nonché (c) eventuali regolamenti interni disciplinino in modo "chiaro" l'accesso al S.I.D. ed il suo utilizzo, nei termini e con le modalità che potrebbero - almeno in via tacita - prefigurare una "volontà di escludere" il militare che violi tali regole, facendo un uso personale (ancor più se pure fraudolento) delle proprie credenziali. Una tale interpretazione dell'art. 615 ter non pare in contrasto col dato letterale: una lettura integrale della disposizione dovrebbe infatti estender l'applicazione della norma anche ai comportamenti eccedenti rispetto alle finalità dell'autorizzazione di accesso ad un determinato sistema. In questo senso, si potrebbe tentare un'analogia con il caso - invero noto alla giurisprudenza in tema di violazione di domicilio - della "domestica" che si trattenga entro l'abitazione del proprio datore di lavoro ed ivi compia atti ulteriori rispetto al proprio compito: in entrambi i casi, infatti, la volontà contraria (presunta o tacita) di chi ha autorizzato l'accesso diverrebbe, a tutti gli effetti, elemento costitutivo del fatto tipico. Non dovrebbe valere in senso contrario, secondo chi scrive, il (pur corretto) richiamo alle sopraccitate considerazioni del Consiglio d'Europa in materia di cybercrimes: se anche là s'invitavano gli Stati contraenti a punire il solo "accesso non autorizzato", bisognerebbe ammettere che, in base al tenore letterale che pare emergere dalla norma, il legislatore italiano - consapevolmente o meno - abbia deciso di oltrepassare tale posizione, nell'ottica di fornire una tutela pi�º ampia ai sistemi informatici[4]. In tal caso, sarebbe poi interessante discutere anche se l'espressione "mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo" intenda o meno considerare un requisito di natura temporale, o invece la concreta finalità dell'accesso. Nel primo caso, sarebbe punibile il solo agente che, intimato (esplicitamente o non) a lasciare un sistema informatico, vi permanga con le proprie (valide) credenziali. Ciò potrebbe però prospettare, a parere di chi scrive, un conflitto con il principio di offensività, laddove il sistema "violato" non contenga dati degni di tutela, ovvero l'attività posta in essere dall'agente non fosse concretamente lesiva (appunto, l'esempio della domestica di cui sopra). Nel secondo caso, invece, sarebbe necessario trovare un ancoraggio chiaro e conforme ai principi costituzionali di legalità e tassatività: se la condotta è punibile in base ad una volontà di un soggetto "terzo" rispetto all'agente, come può l'agente rendersi conto di stare commettendo il reato de quo? Una parziale soluzione, prospettata recentemente dal Tribunale di Brescia (sentenza del 3-30 marzo 2011 n. 293, GUP Dott. Benini, in Corr. merito, 2011, p. 833, con annotazione di Gatta), pare escludere dal novero delle condotte punibili - con un'interpretazione potenzialmente "additiva" - l'attività di un soggetto che, per mera curiosità, si sia trattenuto entro un sistema informatico per cui possedeva le credenziali d'accesso. Il discrimine, in tale caso, sarebbe inerente alle finalità - non illecite - dell'imputato: sarebbe quindi richiesto, per l'attribuzione di un fatto ex art. 615-ter c.p., di un quid pluris (ad esempio, una finalità illecita) che si aggiunga all'elemento materiale del reato. [1] I reati introdotti dalla l. 547/1993 sono stati successivamente integrati e modificati dalla legge n. 48 del 2008. [2] V., inter alia, Cass. Pen. n. 39290/2008, "Peparaio" (erroneamente indicata in ordinanza come n. 3290) in merito a finalità estranee a quelle d'ufficio, e Cass. Pen. n. 26797/2008, "Scimia", in merito - addirittura - a finalità dichiaratamente illecite. [3] Su tutte, la - diffusamente citata nell'ordinanza - Cass. Pen. n. 1727/2008, "Romano", nonché la - risalente, ma cara alla Quinta Sezione - Cass. Pen. n. 12732/2000, "Zara". [4] Si tenga altresì conto, in tale contesto, che la già citata "lista minima" prevedeva ad esempio, quali condotte da sanzionare, anche l'intercettazione di dati non autorizzata e la riproduzione non autorizzata di programmi protetti: potrebbe allora supporsi che anche tali comportamenti siano stati - almeno nelle intenzioni del Legislatore del 1993 - ricompresi proprio nella norma in esame. | |
| Da: ZIO MICHELE | 14/12/2011 12:47:36 |
- Messaggio eliminato - | |
| Da: marò | 14/12/2011 12:48:05 |
| X alvi del 989 d.c.. mi pare Dovresti trovarla sul codice commentato Giustinianeo edizione Giuffrè 989 d.c. anche se essendo di novembre penso sia più facile su quella CEDAM del 990 d.c. | |
| Da: Ro Le | 14/12/2011 12:48:25 |
| ragazzi ma dov'è il parere di anemone? | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ..., 54, 55, 56, 57, 58, 59 - Successiva >>



 Home
Home Quiz concorsi
Quiz concorsi Bandi
Bandi 
 Banche dati
Banche dati Esami e abilitaz.
Esami e abilitaz. Patente nautica
Patente nautica Patente di guida
Patente di guida Medicina
Medicina Download
Download Forum
Forum Registrati
Registrati Facebook
Facebook FAQ
FAQ Chi siamo?
Chi siamo? Contatti
Contatti Login
Login Registrati
Registrati